Il dialetto e i giochi dei bambini
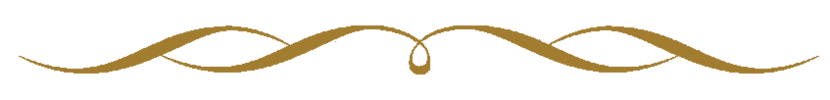
Come si è detto, le persone utilizzavano il dialetto normalmente, e così facevano i bambini. Per questo, anche le filastrocche, le conte e i giochi utilizzavano questa colorita parlata. Ricordiamo alcune filastrocche (le trasposizioni sono approssimative, visto che alcuni giochi di parole sono praticamente intraducibili in italiano, e spesso si gioca sui suoni delle parole, più che sul loro reale significato).
|
Dön dön cavalön va Murtèra a tö i bumbön va Murtèra a tö la brìa dön dön cavalerìa |
Don don cavallone va a Mortara a prendere le caramelle va a Mortara a prendere la briglia don don cavalleria |
|
Tràta büràta la cùa dla mè gata la cùa däl gatìn tràta tràta bürätìn |
Trata burata la coda della mia gatta la coda del gattino trata trata burattino |
|
Suta al pont d’la ciribiriciacula gh’era cincènt ciribiriciaculin. Val pusè la ciribiriciacula che cincent ciribiriciaculin. |
Sotto il ponte della ciribiriciacula c’erano cinquecento ciribiriciaculini Vale di più la ciribiriciacula di cinquecento ciribiriciaculini |
|
Pisìga mugnìga, la gata la riga riga rigò và a cà d’ Burdòn. Sabàt da sìra i galìn i cantavan, fora la mùsca, denta la cràva; oca da plà, pursè da masà, bruta vègia, và a skitlà, và a skitlà ’ntal tò giardìn, par la sir e la matìn. |
Pizzica, aggrinza, la gatta graffia graffio, graffiatura, vai a casa di Bordoni. Sabato sera le galline cantavano; fuori la mosca, dentro la capra; oche da spennare, maiale da ammazzare. Brutta vecchia, vai a cagare, va a cagare nel tuo giardino, e di sera e di mattino. |
|
Minìn, minèla barba Castèla ciòca in tla màn. Indùa t’è ’ndai? A cà d’la Dadò. Sa ca ta dai? ’Na gràna ’d sa. Car car, c’la fuma cantà. |
Minin, minela zio Castella una sberla sulla mano. Dove sei andato? A casa della Dadò. Che cosa ti ha dato? Un grano di sale. Accarezziamolo, e lo facciamo cantare. |
Alcune di queste filastrocche venivano cantate toccando le parti del corpo a cui si riferivano, (“uregia bela...”), e servivano a far ridere i più piccoli, insegnando loro i nomi adatti a indicarle.
|
Urègia belä, so surèlä, ugìn bel, so fradèl, buchìn di frà, campanin da sunà. |
Orecchia bella, sua sorella, occhietto bello, suo fratello, bocchina dei frati, campanello da suonare |
Altre filastrocche sono molto particolari: in un mondo in cui i bambini vivevano a stretto contatto della natura, un gioco molto amato consisteva nel catturare, per esempio, una lumaca, e “convincerla” con la filastrocca a mostrare le sue piccole corna, uscendo dal guscio. Oppure, d’estate, si teneva in mano un bastoncino, e si chiamava una delle tante libellule che volteggiavano nell’aria, chiedendole di posarsi sulla punta della bacchetta. O, ancora, si chiamava una lucciola, di cui le serate estive erano piene, per catturarla.
|
Lusarò, vena bas, che ’l furnè al porta l’as; al porta l’as da fè al pan, lusarò, vena in man. |
Lucciola, scendi giù, che il fornaio porta l’asse; porta l’asse per fare il pane; lucciola, vieni in mano. |
|
Lumàga, lumaghin, tira fora i tò curnin, iun par mi, iun par ti, iun par la vegia c’la vò murì. |
Lumaca, lumachina, tira fuori le tue cornine, una per me, una per te, una per la vecchia che vuol morire. |
|
Siura, siuràta, vena insüma d’la mè bacätü! |
Libellula, vieni sul mio bastoncino! |
Persino il canto degli uccelli veniva tradotto utilizzando delle frasi senza senso, che riportavano i suoni in modo onomatopeico. Ecco come echeggiava, per esempio, il canto dell’usignolo:
|
Camisìn curt curt curt curt... Musträ i ciapp ciapp ciapp ciapp... |
Camicino corto corto corto... Mostra le natiche... |
Il verso del rigogolo, invece, veniva riprodotto così:
| Leru, leru, ’t vò gnì a Vughèru? | Leru, leru, vuoi venire al manicomio di Voghera? |
I treni, poi, tanti anni fa, erano a vapore, e il loro sferragliare suonava più o meno nel modo seguente:
|
Gh’sì tüüüüüüüücccc? Tachèv tacà, tachèv tacà, tachèv tacà... ’m ciapè pù, ’m ciapè pù, ’m ciapè pù... |
Ci siete tutti? Attaccatevi a me, attaccatevi a me, attaccatevi a me... Non mi prendete più, non mi prendete più, non mi prendete più... |
Alcune tiritere servivano a far passare il tempo, quando, per esempio, fuori pioveva; anche in questo caso, non era importante il contenuto della frase, quanto il suono delle parole.
|
Gàta, gatìna, la gàta la fa la farina; al gatìn l’è bel a mort, piòva, piòva pusè fort. |
Gatta, gattina, la gatta impasta la farina; il gattino è morto, piovi, piovi più forte. |
Un esempio di ninnananna, poi, era questo:
|
Dandarandàn, Lusìa, suta cul casinòt al gh’era na vègia strìa ch’la fava balà i bigòt. |
Dandarandàn, Lucia, sotto quel cascinotto c’era una vecchia strega che faceva ballare le bambole. |
Indovinelli in dialetto
La va, la va, la porta drè la so cà = Va e va, e porta dietro la sua casa (= la chiocciola)
La va, la vena e par la cùa la tena = Va e viene, e lo tengo per la coda (= l’aratro)
Un butalìn cun denta do qualità ’d vin = una piccola botte che contiene due tipi di vino (= l’uovo)
Filastrocca in dialetto
Per approfondire in modo adatto tutte le sfumature del dialetto occorrerebbero molto tempo e molte pagine; per finire questa breve trattazione, ecco una bella poesia in dialetto paronese, che percorre con fantasia i mesi dell’anno:
Una anàda mès par mès
|
Genàr
L’an növ l’ha fai che nàs,
l’è incùra tut fasà ’ntla fioca e la brumèra, al piansa par la fam. Sa t’è masà ’l pursè prapara la rustìda e trusa la pulenta... s’la da gnì grand. |
Gennaio
L’anno nuovo è appena nato,
è ancora tutto fasciato nella neve e nella bruma, piange per la fame. Se hai ucciso il maiale prepara la Rustìda e gira la polenta... se deve crescere. |
|
Febràr
Dop i dì d’la merla
la pruma spèrla ’d sù la fa svigè la rana, la bisa e ’l risfurchìn. Se ’d sira gh’è la luna, ad nocc l’è tuta nèbia: a l’ombra dal paiè la prìna la risìsta. |
Febbraio
Dopo i giorni della merla
il primo raggio di sole fa svegliare la rana, la biscia e il porcospino. Se di sera c’è la luna, di notte è tutta nebbia: all’ombra del pagliaio la brina resiste. |
|
Mars
Aqua tut al dì
o vent e tanta su. Su i ram d’i piànt gh’è i but ch’i rìdan, cuntènt da ved rivè la pruma rundanìna cun tucc i so parènt dal nì fai l’an pasà. |
Marzo
Acqua tutto il giorno,
o vento e tanto sole. Sui rami degli alberi ci sono le gemme che ridono, contente di veder arrivare la prima rondinella con tutti i suoi parenti nel nido costruito l’anno scorso. |
|
Aprìl
Che bel drumì se piòva
e salta ’na quai gùta sul vèdar dla tò fnèstra! Ma prest ta svigiarà ’na bèla campanàda dla Pasqua ch’lè rivà o ’l cip di pulastrìn ch’i plùcan suta ’l scràsi. |
Aprile
Come si dorme bene se piove,
e qualche goccia salta sul vetro della finestra! Ma presto ti sveglierà una bella scampanata della Pasqua che è arrivata o il pigolio dei pulcini che razzolano sotto il cesto. |
|
Magg
Dadlà dal foss
mila papàver russ intal furment ch’lè incura verd; dadchì ’l maseng fai che taiè cu’i ran ch’i saltàn da l’àrsan intal ris. |
Maggio
Dall’altra parte del fosso
mille papaveri rossi tra il frumento che è ancora verde; da questa parte il maggengo appena tagliato con le rane che saltano dall’argine dentro la risaia. |
|
Giugn
Dop l’ùltim dì da scòla
i fiò, a pè par tèra, i cùran pr’i sintè e i van catè i muròn. Int’l’era giamò scuà l’amsùra dal furmènt la cut e la caplìna ian pront da fè ’l racòlt. |
Giugno
Dopo l’ultimo giorno di scuola
i bambini, a piedi nudi, corrono per i sentieri e vanno a cogliere le more del gelso. Nell’aia già pulita la falce del frumento gli attrezzi e il cappello sono pronti per il raccolto. |
|
Lùi
Fa un cald d’infèran;
a l’ombra d’una gaba l’acqua dal barlet la psinta ten’mè ’l fum. la giàsa d’la giasèra la slengua mè ’l butìr. As cùra a fè la nòda intal bùri dal cunsòrsi. |
Luglio
Fa un caldo infernale;
all’ombra di un salice l’acqua del barilotto svanisce come il fumo. Il ghiaccio della ghiacciaia si scioglie come il burro. Si corre a nuotare nel canale del consorzio. |
|
Agùst
Intla riva dal canàl,
cun cald e umidità, trionfa i arbasòn, i galùri e i martinè. Ma dop al feragùst ga scòpia un timpuràl cun fùlmin e timpèsta ch’al par al finimònd. |
Agosto
Sulla riva del canale
con il caldo e l’umidità trionfano le erbacce, gli afidi e i calabroni. Ma dopo Ferragosto scoppia un temporale con fulmini e grandine che sembra la fine del mondo. |
|
Setèmbar
Al su ch’al brìla
e ’l sùga la rùsa sul pum e su la spìa: sicònda primavera. Madùra tucc i frutt: i pèr e l’uga màta, tumàtich e pivròn. Che festa la natùra! |
Settembre
Il sole che brilla
e asciuga la rugiada sulla mela e la spiga: seconda primavera. Maturano tutti i frutti: le pere e l’uva matta, i pomodori e i peperoni. Che festa la natura! |
|
Utùbar
A l’ombra dàl gisiòn
s’impàsta la farina cun i ov incùra tèvi, al sùcar e ’l bütìr. In piàsa e par i strà gh’è aria ad dì d’la festa: finì tucc i racòlt par prèmi gh’è i ufèl. |
Ottobre
All’ombra della chiesa
si impasta la farina con le uova ancora tiepide, lo zucchero e il burro. In piazza e per le strade c’è aria di giorno della festa: terminati tutti i raccolti, per premio ci sono le offelle. |
|
Nuvèmbar
D’in piàsa al cimitèri,
’na pursisiòn d’umbrèl. E ’d sìra rènta ’l fòch rusàri e castègn sech. Al dì dal San Martìn agh rìva l’ùltim su pr’i pùli di fitàvul e i sèp cüi gabarò. |
Novembre
Dalla piazza al cimitero,
una processione di ombrelli. E di sera, vicino al fuoco, rosario e castagne secche. Il giorno di San Martino arriva l’ultimo sole per le pulci degli affittuari e i ceppi con i funghi. |
|
Dicèmbar
Gh’è da sciapè la legna
e purtè cà la täpä da mèt intàl presèpi pruma ca fiòca. E pö vena Nadàl e San Giusèp cun l’àsu ’l porta la Madòna... e ’gh nàsa ’l so Bambìn. |
Dicembre
Bisogna tagliare la legna
e portare a casa il muschio da mettere nel presepe prima che nevichi. E poi arriva Natale e San Giuseppe con l’asinello che porta la Madonna... e nasce il suo Bambino. |